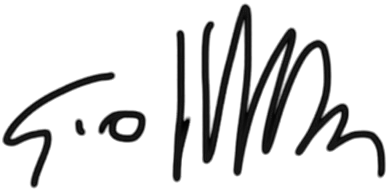Altri libertini. Solitari, sconfitti, distaccati, ribelli.
L’atmosfera del romanzo “Rimini”, di Pier Vittorio Tondelli, uscito per Bompiani nel 1985, è cupa, come lui tenne a sottolineare in più interviste, mentre il pubblico lo leggeva (furono più di 100.000 le copie vendute) come libro da spiaggia, come testo d’evasione, quale azzeccata trovata postmoderna.
In quell’opera narrativa, la terza scritta dal Pier nazionale, il dissesto dominava, affogato da cento chilometri di costa adriatica non vissuti quali ‘divertificio’, ma come punto massimo della presa di coscienza di una condizione da personaggi più vicini al tono provocatorio di una fanzina satirica anni ’70 che alla tipicità di un componimento intriso di canoni ‘eccezionali’ anni ’80 (anche se “Rimini” è lo scritto più convenzionale stilato da Tondelli), così che il coro degli astanti, tirati in ballo in quelle pagine, interpretava l’inno degli sconfitti e non il trionfo dei borghesi vincitori… o pensati come tali, visto che sempre i soliti cinque (boss), e non i milioni di italiani, infine (e come sempre) portarono a casa il risultato, alla faccia di chi sventolava bandiere rosse o indossava passamontagna neri.
Si era usciti da poco dai cosiddetti “anni di piombo”, da una Italia in persistente guerra civile, dalla rabbia improduttiva e spesso pasticciata di una generazione, così che l’edonismo di superficie avanzò, vanificando, in seguito, poi fino in fondo, i gesti di ribellione, “l’immaginazione al potere” o le mani sollevate in aria facenti il segno della P38, seppellendo definitivamente tutte le vittime cadute per un ideale o per aver obbedito agli ordini, a volte spietati, di uno Stato e di un entourage politico che per nulla avevano inteso il cosa stesse succedendo o, forse meglio, che più che bene lo avevano inteso, al punto di fomentare strategicamente discordie e quindi mandare i blindati a sedare le convulsioni di una Bologna in mano all’Autonomia e agli Indiani Metropolitani. Una Bologna che fu di Tondelli, di Pazienza, di Freak Antoni e dei suoi Skiantos, di Lindo Ferretti, di ‘Bifo’, dell’Alinovi e di infiniti altri che poi molto hanno dato alla nostra cultura, sia underground sia accademica.
Quelli furono anche i miei anni, e quelli di artisti altrettanto “irregolari” come i riminesi Giò (Giovanni) Urbinati e Vittorio D’Augusta, quindi del cotignolese Claudio Montini, del lughese Piero Dosi e del faentino Danilo Melandri… personaggi che tramite il loro fare continuarono a opporsi a ciò che reputavano un sistema sbagliato, un mondo in mano ai tiranni, agli opportunisti, agli affamatori, ai faccendieri, ai pirati… un mondo in cui l’uomo comune veniva messo al muro obbligandolo a consumare, a recitare una parte, a imbellettarsi di ipocrisia.
Di solito le ‘sconfitte’ hanno una cattiva reputazione (soprattutto quelle rivoluzionarie); le vedi come delle debolezze, delle irrecuperabili cadute, invece, a volte, sono sane acquisizioni di esperienza, e questo in tutti i campi.
Il filosofo, scrittore, sociologo, giornalista, docente francese Charles Pépin nel suo “Les vertus de l’échec”, libro del 2016, ha guardato in modo nuovo alla sconfitta. Al pari degli stoici l’ha vista come un incontro privilegiato con la realtà, e, come gli esistenzialisti, quale opportunità di reinvenzione. Nel suo libro trovate saggezza nelle parole di Miles Davis e nelle poesie di Kipling, nelle batoste prese da un giovane tennista di nome Rafel Nadal, nei disastrosi esperimenti di Edison, poi le testimonianze di Marco Aurelio, Charles de Gaulle, San Paolo, Steve Jobs, Nietzsche, Freud, Bachelard, J.K. Rowling e Sartre, così da scoprire che mai come nel perdere, in tutte le accezioni, si impara a sorprenderci di noi stessi e sempre più, a seguito, diviene importante e solido il nostro esprimerci, il nostro proporci.
Giò (Giovanni) Urbinati (Rimini 1946 – Rimini 2023) scultore e ceramista, oltremodo caro al poeta Tonino Guerra, lo si andava a trovare nella sua bottega in Via Alda Costa numero 4 in cui regnava una sorta di “disordine organizzato”. Quali le sue frequentazioni? Carla Birolli, tramite la quale ebbe l’occasione di affacciarsi al mondo del lavoro legato alla ceramica, Cesare Filippi, pittore e incisore, Benito Balducci, pittore, Rosetta Tamburini, pittrice e ceramista. Quindi, così come ho detto, nel 1988 ecco l’incontro con Tonino Guerra dal quale nascerà una loro prima mostra: “La cattedrale dove va a dormire il mare”, poi, successivamente, sempre assieme diedero vita a “Il giardino pietrificato”, a “L’arco delle favole per gli occhi dell’infanzia” e a tante altre opere ed eventi. Arte, quella di Urbinati, a momenti oltremodo decorativa, poetica, ispirata dalla natura, dagli animali, dagli insetti, quindi i suoi piccoli teatri (scatole in terracotta contenenti oggetti e simboli), poi le case stilizzate… tante, una sopra l’altra, ammucchiate, a formare colline e montagne aventi il sospiro di un persistente presepio. Diceva di sé: “Nel 1969 ho aperto una mia bottega, avviando così un lavoro di sperimentazione, scultura e soprattutto ricerca sugli smalti e cotture a lustro. In questo modo sono arrivato a toccare l’alchimia. Ho lavorato e cotto tutto quello che era possibile: dalla terra del mio giardino al gres più duro, alla porcellana più raffinata. Dopo diversi anni di cotture in forno con strumenti pirometrici sono arrivato alla cottura ad occhio, guardando dal rosso rubino del piccolo fuoco, al bianco luce dei 1350 gradi centigradi”. Giò, di per sé già autodidatta, ha trovato nel corso del tempo e in autonomia la chiave per darsi le sue più intime ragioni nel processo plastico. Questo suo calarsi nell’avventura della materia con una complicità quasi genetica, palesemente erotica e dirompente, alla ricerca di una autenticità di forme e di pensieri, ha radici lontane, alimentata dal suo stesso raccontarsi, tra istintiva capacità ed ebbrezza nello scoprirsi abile con la creta. Giò… artista che sapeva che oltre il blu più limpido esistono altre, ed altre ancora, intensità di blu… quasi infinite.
Vittorio D’Augusta (Fiume, 1937) giunto a Rimini quasi nell’immediato dopoguerra, maestro riconosciuto, già noto negli anni ’70 per la sua cosiddetta arte “povera”, ambientale, attenta ai valori fondamentali della pittura, di lui, nei lustri successivi, per tale componente, si è interessato una fine mente come quella di Giovanni Accame che del nostro ha scritto: “Nella dilatazione e trasformazione dei suoi confini, le ‘fisicizzazioni’ delle sue più specifiche caratteristiche, come colore, luce, stesura, ottenute con materiali diversi, toccano e sollevano tutti i problemi di una differente pratica della pittura e della sua immagine. L’atteggiamento di D’Augusta verso il dipingere è sempre allusivo, non gli si pone mai di fronte, ne svela la presenza percorrendone le più riposte cadenze. Quelle fettucce, feltri, ovatte, che nel ’75 fuoriuscivano appena imbevute di colore da sotto lastre di piombo o scendevano lungo tele solo fugacemente toccate di bianco, erano un’estensione del fare pittura che avrebbe portato alla sua attuale apparizione”. A seguire ecco l’astrazione organica, l’informale, la resa spaziale di strutture e simboli geometrici e il suo esporre non solo in Italia ma anche all’estero. L’altrettanto romagnolo Flavio Caroli si è interessato a fondo del suo lavoro; Renato Barilli lo ha inserito in alcune importanti mostre e così Achille Bonito Oliva. Nel 1987 Cortenova lo ha chiamato a partecipare a un’altra rassegna di rilievo: “Astratta, secessioni astratte in Italia dal dopoguerra al 1990”. Seguirono mostre all’estero… in Austria, in Germania e in Francia. Di sé recentemente ha detto: “Sebbene agnostico, o, meglio, diversamente credente, da un qualche anno ho dipinto cento croci, o, più esattamente, ho messo una croce sopra fogli in parte già dipinti. Dipinti, però, con troppa disinvoltura e a mente vuota, ma con ostinata fiducia nell’antica pratica della pittura che consente la libertà di ‘errare’, nel senso doppio di vagabondare e di sbagliare, entrambe esperienze di felicità rischiosa”. Artista, D’Augusta, per il quale l’astrazione purifica, per cui l’astrazione diviene un assoluto, come assoluta, nel nostro universo, risulta, a nostro avviso, unicamente l’energia… in particolare quella vitale.
Claudio Montini (Bagnacavallo, 1956 – Faenza, 2021) è stato un genio del pennello. Da un impianto romantico-illustrativo ha raggiunto livelli pittorici raffinatissimi. Interessato alle tendenze musicali e di costume della sua generazione, si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna. In seguito ha esposto pochissimo, e soprattutto in area romagnola. Negli anni sempre più si è ritirato a vita privata e sempre meno ha dipinto, privilegiando soggetti sempre più ironici, favolistici-fantasiosi, simbolici e visionari. Di lui ha scritto, con acume, Franco Pozzi: “Claudio Montini appartiene di diritto alla schiera di artisti che lavorano senza l’assillo del mercato. Coltivando e ammansendo quotidianamente un demone personale, ma senza forzare il proprio ritmo interno. Nella sua non breve carriera, con discrezione non comune, in un «voyage autour de sa chambre» ha prodotto immagini di una qualità altissima. Ad un primo sguardo, mai quelle tele e carte tradirebbero gli interessi del giovane Montini studente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna – dove negli anni Settanta chi si affidava alla pittura veniva guardato con sospetto, considerato fuori tempo massimo – affascinato dalla cultura musicale underground, in particolare quella punk. […] Forse l’unico riferimento certo di Montini fu il ‘nume’ William Turner. I suoi dipinti sembrano imbevuti nella medesima atmosfera costruita con la pennellata franta del grande innovatore inglese che, eccentrico e provocatore, pare si facesse legare al pennone di una nave durante una tempesta, per potere poi trasferire quella visione sulla tela. Ma molti sono gli echi che la pittura di Montini è in grado di evocare, in una sintesi personale, qualitativamente sempre elevata. Victor Hugo, Gustave Moreau, Odilon Redon, Mikalojus Kostantinas Ciurlionis, Antonio Fontanesi, Fernand Khnopff, Franz Von Stuck sono i primi nomi che mi balzano agli occhi guardando le opere di questo appartato «pittore dell’immaginario». In lui, però, quei modelli vengono mescolati a immagini non solo cinematografiche, anche televisive e pubblicitarie, in un processo di continua distillazione del visibile”. E così, sempre di Montini, ha scritto il decano Franco Bertoni: “In realtà l’ ‘iceberg Montini’ ha trasportato, sotto il pelo dell’acqua, una massa enorme di bellezze, di sogni, di enigmi, di interrogativi, di fantasie e di aperture a nuovi mondi. Per non parlare poi di una tecnica esecutiva – in Romagna viene chiamata la ‘mano del Signore’, un dono – talmente felice e immediata da raggiungere l’apparente facilità riservata solo ai Grandi”. Per Montini la componente romantica risultava quale giudizio nei confronti di una società, non certo voce della stessa.
Piero Dosi (Lugo, 1946 – Lugo, 2016) un altro virtuosista del pennello. Così di lui ha detto il sempre bravo Claudio Musso: “È molto difficile inserire un artista, che per scelta lavora ai margini, in un discorso corale, tanto meno nella logica del gruppo. Di certo Dosi condivide con alcuni suoi coetanei in Italia, penso ai protagonisti della Transavanguardia, ai Nuovi Nuovi, un ritorno alla pittura e una vocazione citazionista che nelle sue opere è visibile come copia/omaggio, da Bonnard a Kandinskij. Per la violenza espressiva del suo segno pittorico, ma in particolare nelle opere su carta, Dosi appare spesso come compagno di viaggio degli autori tedeschi e austriaci della sua generazione, come i Neuen Wilden (i Nuovi Selvaggi), pur mantenendo una forte identità nel suo cammino individuale e solitario”. E così sempre Musso ha scritto: “Negli anni Settanta e Ottanta prevale, in lui, un approccio alla figurazione di tipo iperrealista, ma le rese quasi fotografiche dei soggetti (ritratti e autoritratti) sono sporcate da apparenti strappi, da scritte, da sovrapposizioni che mimano la tecnica del collage e da dettagli che ricordano le deformazioni corporee di Francis Bacon. Questo gioco al massacro dell’immagine (operata tra riferimenti al Surrealismo, a Magritte e all’Art Brut) trova momentanea fine al momento del suo trasferimento in Valle Santa, oasi naturalistica del Delta del Po. Qui, il rapporto con la natura lo porta a rassodare la sua pittura che trova inediti accenti vitalistici in un originale e antigrazioso mix di futurismo, fauvismo e divisionismo: aspetti che torneranno nel suo lavoro dopo una parentesi (anni Novanta) quasi astratta, informale e, a volte, anche decorativa. Pur utilizzando colori caldi e squillanti, Dosi è impietoso nei confronti dei suoi soggetti e la lunga serie degli autoritratti non è altro che una continua indagine sul tempo e sulle insanabili conseguenze che il suo scorrere comporta. Spesso, le sue ultime opere sono realizzate con due o più tele, quasi a sollecitare un ideale e potenziale accorpamento di tutto il suo lavoro lungo una linea narrativa senza soluzione di continuità”. Piero fu pittore e uomo di somma levatura, sia per sensibilità, per educazione, per amorosità. La sua morte, come poi quella di altri qui in mostra, ha lasciato indubbiamente un grande vuoto nella nostra geografia e in me. Per Piero, alla pari di Paul Cézanne, dipingere l’essere umano o la natura non indicava il cogliere un soggetto, il rappresentare un’argomentazione, bensì il concretizzarsi di sensazioni.
Danilo Melandri (Fognano di Brighella, 1948 – Faenza, 2018) iscrittosi all’Istituto d’Arte per la Ceramica di Faenza in esso l’unica figura che scelse quale riferimento, in una scuola che pur annoverava fra gli insegnanti maestri quali Angelo Biancini, Carlo Zauli, Augusto Betti e, tra le nuove leve, Alfonso Leoni, fu Gianna Boschi, pittrice e ceramista dagli interessi apparentemente passatisti e antimoderni. Oltre al solito facimento della ceramica tradizionale faentina, Melandri, entro la sua bottega, iniziò a produrre piccoli oggetti in maiolica policroma… piattini, lastrine, formelle, micro sculture di pochi centimetri… sui quali interveniva con frasi, annotazioni, pagine di diario, usando una calligrafia minutissima. Il tutto, sempre più, risultò maniacale, ossessivo, nonché una profonda opera di introspezione in cui temi cari a lui bambino si mischiavano con i persistenti turbamenti dovuti al trovarsi immerso in una modernità e postmodernità in cui un macchinismo pesante, distruttivo e portatore di morte, incombeva con sempre maggiore pressione sull’essere umano, ormai votatosi a un tecnicismo esasperato e al tecnologico avanzato. Danilo era uomo puro, attento, rispettoso, altamente emotivo a cui, come agli altri qui presentati, ho voluto e ancora voglia molto bene. Il dialogare con lui ti proiettava in mondi lontani, sia dal punto di vista religioso sia sociale, in modo che il costruire assieme “oasi di salvezza” diveniva di una facilità estrema. Stupenda la sua modestia, come poi quella di Dosi, e sempre calorosa e partecipe la sua presenza. Inutile ribadire che il microscopico e il macroscopico, quale ‘vedente’, non quale ‘visionario’, si fondevano nel suo fare amanuense miniaturista. Diede forma anche a piccole sculture in plastilina, mentre si circondava di materiali bellici di recupero, a volte riempiendone la bottega in cui, in un angolino, lavorava ai suoi ceselli e ai suoi ricami. Per Danilo Melandri il vivere era condizione semplice, mentre il pensare diveniva sublimità di una ricerca votata a una armonica situazione di passaggio da una società, sana, di stampo rurale a quella in mano ai ‘tecnocrati’… cupi maghi della velocità e del cinismo.
Gian Ruggero Manzoni